L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 26 luglio, ha autorizzato con condizioni…
Crisi e Resilienza del Diritto d’Autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790
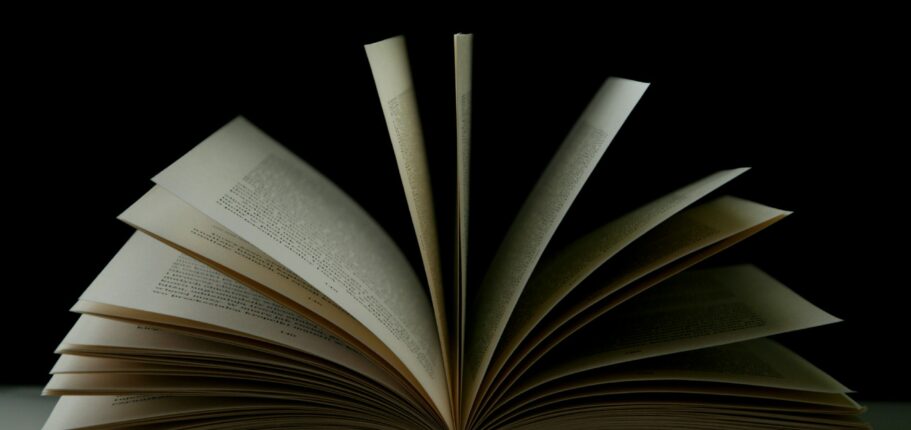
Crisi e Resilienza del Diritto d’Autore. Il recepimento italiano della direttiva 2019/790
(Roma, 21 maggio 2024)
Il volume che ho il piacere di presentare raccoglie gli interventi svolti in un ciclo di seminari organizzati dal Gruppo italiano dell’Associazione letteraria e artistica internazionale sul tema della trasposizione nel nostro ordinamento interno della direttiva europea sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Il libro è dunque il frutto di un’iniziativa – quella di ALAI Italia – che definire meritoria è persino riduttivo, poiché ha dato vita non a una semplice raccolta di saggi, ma a un vero e proprio commentario di straordinario valore, completezza e organicità.
Organicità che non vuol dire, peraltro, appiattimento e omologazione dei punti di vista, delle sensibilità diverse che inevitabilmente si riflettono negli interventi degli autori di un volume collettaneo. Vi è tra loro chi è attento in primo luogo all’esigenza di salvaguardare la proprietà intellettuale in un’epoca in cui l’evoluzione della tecnologia rischia di comprometterne la tutela. Chi si mostra preoccupato di non restringere il campo delle eccezioni e limitazioni, ossia degli accessi legittimi ai contenuti. Chi, ancora, esamina le norme vagliandone soprattutto l’efficacia ai fini del corretto funzionamento del mercato. Angoli visuali che, se pure non coincidenti, sono però complementari, piuttosto che contrastanti, poiché consentono di approfondire la conoscenza della materia a trecentosessanta gradi.
Tutti i contributi, poi, sono connotati, oltre che dall’elevato pregio scientifico, dalla medesima impostazione metodologica. Mi riferisco al serrato raffronto tra le disposizioni della direttiva e quelle del decreto legislativo di recepimento, che fa talora emergere – pure nel quadro di un commendevole impegno del legislatore delegato – anche discrasie e incongruenze. E ciò sia nel senso della mancata trasposizione di clausole contenute nel testo da recepire, sia, all’opposto, in quello dell’inserimento nella legge sul diritto d’autore di prescrizioni non sempre del tutto coerenti con gli obiettivi della disciplina eurounitaria. Obiettivi – richiamati già nella prefazione di Valeria Falce – che rappresentano il criterio-guida unificante dell’interpretazione della normativa e che possono sintetizzarsi nell’adeguamento dell’istituto del copyright alla luce della rivoluzione digitale e nella ricerca di un equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli degli utilizzatori dei contenuti. In quest’ottica la direttiva si propone il chiaro intento di promuovere lo sviluppo del mercato della concessione delle licenze, in modo da far godere ai titolari i benefici derivanti dallo sfruttamento dei loro diritti e da assicurare nel contempo la più ampia circolazione e fruizione delle opere. Il tutto rispettando l’autonomia negoziale delle parti, non ostacolando il progresso tecnologico, nonché salvaguardando la libertà di espressione.
Compito tutt’altro agevole, come si può comprendere soprattutto considerando che l’evoluzione incessante e rapidissima della tecnologia espone costantemente le regole giuridiche al rischio di una rapida obsolescenza. Niente vale a dare la misura di questo problema quanto l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, con le sfide che comporta per la tutela dei diritti autoriali, come non ha mancato di rilevare Maria Letizia Bixio, che è anche la curatrice del volume. Avverte giustamente a questo proposito Deborah De Angelis che la massa dei dati utilizzati per addestrare gli algoritmi ha dimensioni tali da non consentire nella pratica l’individuazione di tutte le singole opere interessate dall’attività di web scraping. Questa considerazione mi rafforza nel ritenere l’AI Act un’occasione perduta dal punto di vista del diritto d’autore, la cui tutela continua ad essere affidata, nei confronti dell’intelligenza artificiale generativa, all’opt-out richiesto dalla direttiva copyright per sottrarre le opere all’eccezione di text and data mining. Il timore di penalizzare lo sviluppo della tecnologia ha prevalso, ancora una volta, sull’esigenza di tutelare in maniera efficace i diritti autoriali, come sarebbe avvenuto sostituendo l’opt-out con la previsione di un opt-in quale condizione per rendere possibile l’operatività dell’eccezione, ossia per consentire l’estrazione di testo e di dati dai contenuti protetti.
Tornando alla direttiva copyright, solo il tempo potrà dire se la sua applicazione concreta da parte degli Stati membri avrà consentito di perseguire efficacemente gli scopi prefissi. Per quanto riguarda il nostro Paese, questo volume rappresenterà di sicuro una guida preziosa per gli interpreti, per gli operatori e per tutte le categorie interessate, oltre che per il regolatore, chiamato dal decreto legislativo di recepimento a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione della normativa. Ed è altresì auspicabile che le indicazioni presenti in molti dei saggi che compongono l’opera siano tenute in conto dal legislatore per porre rimedio agli aspetti critici che caratterizzano in alcuni casi la trasposizione della direttiva nel diritto interno.
Ho trovato quanto mai indovinata la scelta del titolo del volume: crisi e resilienza del diritto d’autore. La crisi, come ho già accennato, è ovviamente connessa all’irruzione sulla scena della tecnologia digitale. La quale per un verso ha consentito una diffusione incomparabilmente più ampia dei contenuti, ma ha reso nel contempo assai più agevole, per altro verso, la violazione dei diritti autoriali. E non solo. La nuova tecnologia ha determinato inoltre l’affermazione, favorita dalla carenza di regole, di modelli di business quanto mai aggressivi, che hanno privato i titolari della massima parte del valore generato dallo sfruttamento delle opere, a tutto vantaggio degli intermediari che operano in rete. Questi effetti sono stati poi ulteriormente aggravati da un’idea distorta della libertà di internet, una sorta di feticcio che si voleva dovesse giustificare il sacrificio di altri diritti ritenuti di rango inferiore, quale la proprietà intellettuale, ridotta tra l’altro alla sua sola componente economica. Ne ho fatto personalmente l’esperienza in quanto a suo tempo artefice del regolamento dell’Agcom per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
In seguito il clima e il sentimento della pubblica opinione sono fortunatamente cambiati, contribuendo così alla resilienza del diritto d’autore. Ne è prova il mutamento dell’approccio nei confronti della rete da parte delle istituzioni europee, le quali hanno adottato, come nota Alessandro Enrico Cogo, una strategia ispirata dalla convinzione che la garanzia degli interessi pubblici e di quelli privati nell’ambiente digitale non possa prescindere dalla messa in atto di un idoneo apparato regolatorio.
L’importanza della direttiva quale prova della resilienza del copyright si coglie ancor meglio se se ne ricorda l’iter assai travagliato a causa di un’azione di lobbying di un’ampiezza che ha pochi uguali nella storia dei parlamenti. L’approvazione dell’atto ha rappresentato pertanto un successo delle istituzioni europee, persino al di là della portata normativa del testo.
Stefania Ercolani ha parlato di resilienza anche riferendosi alla capacità di adattamento alle novità e agli aggiornamenti dimostrata per l’ennesima volta, con la trasposizione della direttiva copyright, dalla legge italiana sul diritto d’autore. Non sempre, però, gli innesti hanno prodotto esiti felici. Paolo Marzano ha messo in luce, ad esempio, che il comma aggiunto all’art. 107 della legge determina una duplicazione dei compensi già previsti da altre norme della stessa legge a favore degli autori e degli AIE, con il risultato di rendere più onerosa – e quindi presumibilmente di ostacolare – la produzione di nuove opere audiovisive.
Analizzando anch’essi la trasposizione delle norme della direttiva concernenti l’equa remunerazione di autori e artisti, Fabio Ghiretti e Giovanni d’Ammassa hanno entrambi sottolineato che il rafforzamento della posizione dei creativi si giustifica con l’esigenza di tutelare il contraente più debole. Ghiretti ha rilevato tuttavia che la mancata previsione, da parte del legislatore nazionale, delle deroghe agli obblighi informativi contemplate dall’art. 19 della direttiva ha reso tali obblighi eccessivamente onerosi per gli utilizzatori. A questa manchevolezza ha provvidamente posto rimedio l’Agcom, che ha recuperato le deroghe, facendone espressa menzione nel regolamento attuativo ancora in itinere all’epoca della redazione del volume e pubblicato nei giorni scorsi.
Accenni critici sul recepimento si ritrovano anche in altri contributi. Fabiola Massa lamenta il disallineamento dell’art. 70-bis rispetto all’art. 5 della direttiva in tema di eccezione per uso didattico, paventando il rischio di un deferimento della questione alla Corte di giustizia. A loro volta, Stéphanie Rotelli e Costantino Monteleone si soffermano su alcune incongrue disparità di trattamento determinate dalla insoddisfacente trasposizione dell’art. 14 quanto alla protezione dei documentari non creativi.
A ragione, Simona Lavagnini manifesta più di un dubbio sulla legittimità costituzionale dei poteri paragiurisdizionali attribuiti ad Agcom da alcune disposizioni del decreto legislativo, le quali statuiscono che spetti in via esclusiva all’Autorità determinare, in difetto di accordo tra le parti, la remunerazione o il compenso dovuti al titolare del diritto d’autore o di un diritto connesso. Rilevo per parte mia che alla palese incostituzionalità della norma primaria Agcom ha pensato di rimediare inserendo nel regolamento attuativo una norma secondaria costituzionalmente orientata ma illegittima, in quanto prevede – in chiaro contrasto con la lettera del decreto legislativo – che sia possibile adire l’autorità giudiziaria in alternativa alla promozione del procedimento dinanzi all’Autorità. Un bel cortocircuito normativo, non c’è che dire.
Non aderenti al ruolo tipico di un’autorità amministrativa indipendente sono anche le funzioni di consulenza assegnate ad Agcom dall’art. 110-ter ai fini del raggiungimento di accordi contrattuali per la concessione di licenze relative allo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Chiara Marchisotti non manca di rimarcare questa anomalia, riconoscendo comunque che nel regolamento attuativo più volte citato Agcom è riuscita a delineare un meccanismo rispettoso dell’autonomia negoziale delle parti e coerente con le finalità tenute di mira dal legislatore europeo, finalità ricostruite anche nel contributo di Chiara Dellacasa.
Venendo alle misure specificamente volte a garantire un accesso più ampio ai contenuti, Piero Attanasio e Raffaella Pellegrino hanno segnalato criticamente, al pari di Maria Letizia Bixio, che l’eccezione per le opere fuori commercio per le quali manchino organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi, prevista in termini generali dall’art. 8 della direttiva, è stata inopinatamente limitata, dal legislatore nazionale, soltanto alle banche dati e al software. In tema di tutela e conservazione digitale a lungo termine del patrimonio culturale, va poi tenuto nel massimo conto il rilievo di Rosa Maiello, Giuseppe Mazziotti e Cristiana Sappa, i quali avvertono che si tratta di un servizio pubblico necessario, troppo costoso perché lo si possa demandare prevalentemente al mercato.
Le censure più aspre hanno riguardato il recepimento delle norme sulle licenze collettive con effetto esteso, e in particolare la previsione secondo cui tali licenze possono essere concesse dai tre OGC maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti, senza che sia richiesto, dal nuovo art. 180-ter, il requisito della sufficiente rappresentatività contemplato dall’art. 12 della direttiva. Questa scelta del legislatore delegato ha suscitato dissenso unanime nei commentatori. Attanasio e Pellegrino l’hanno definita contraria alla direttiva e inefficiente dal punto di vista dell’analisi economica, Davide Sarti infelice e probabilmente incostituzionale. Ugualmente negativa è l’opinione espressa da Paolo Cuomo e da Andrea Miccichè, il quale ultimo ha altresì fatto presente la concreta impossibilità di individuare gli apolidi senza la costituzione di una banca dati unica, possibilmente ubicata presso l’Agcom.
Ricordo che una proposta in tal senso da me avanzata al tempo in cui ero componente dell’Autorità ebbe a scontrarsi con l’opposizione irriducibile delle collecting più piccole. Né miglior fortuna ha avuto, in tempi più recenti, il mio auspicio che l’Agcom recuperasse, nelle norme del regolamento attuativo concernenti le licenze collettive estese, il criterio della sufficiente rappresentatività delle collecting presente – come ho detto – nella direttiva.
Valutazioni complessivamente più positive ha ricevuto il recepimento degli artt. 15 e 17, ossia delle due norme della direttiva più contestate a suo tempo dagli ambienti meno sensibili alla tutela del copyright.
Gustavo Ghidini e Giovanni Cavani hanno sì lamentato – al pari di Alberto Musso – la progressiva riduzione degli spazi di accesso alle opere rispetto al regime della Convenzione di Berna, svolgendo inoltre una pregevole analisi del concetto di opera derivata. Ma hanno nel contempo avvertito che questo effetto è imputabile alla tassatività delle eccezioni e limitazioni stabilita dalla direttiva infosoc, piuttosto che all’art. 17 della direttiva copyright.
Commentando quest’ultima disposizione – recepita in termini pedissequi dal legislatore nazionale – Stefania Ercolani ne ha sottolineato la natura di lex specialis rispetto alla disciplina generale contenuta nella direttiva e-commerce, come integrata dal Digital Services Act. Anche Alessandro La Rosa si è soffermato sulle innovazioni introdotte dall’art. 17 in ordine al regime di responsabilità degli online content sharing service provider e sul carattere di specialità di tale norma. E ha tratto da ciò la conclusione della inapplicabilità, in materia di copyright, dei requisiti più stringenti richiesti in linea generale dal DSA per le segnalazioni volte a ottenere la rimozione dei contenuti illegali.
Quanto all’art. 15, Isabella Splendore ha messo in evidenza che il recepimento italiano rappresenta un benchmark a livello europeo, imperniato com’è su un meccanismo di negoziazione assistita volto a garantire l’effettivo godimento del diritto connesso attribuito agli editori di giornali. Il riconoscimento agli editori di un equo compenso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni è apparso peraltro a Francesca Giordanelli innovativo rispetto alla norma europea, dalla quale però deriva, a mio avviso, come logica e legittima conseguenza. A sua volta, Paolo Marzano ha dimostrato la coerenza con l’art. 15 della scelta del legislatore nazionale di inserire le imprese di media monitoring e di rassegna stampa fra gli operatori tenuti a versare il compenso agli editori.
Meritano di essere ricordate, infine, anche le riflessioni di Gianluca Pojaghi in tema di reprografia e di copia privata, nonché la puntuale ricostruzione, ad opera di Beatrice Cunegatti, delle nozioni di editore e di autore ai fini dell’applicazione delle norme che hanno recepito l’art. 16 della direttiva.
A questa preziosa opera collettanea ciascuno degli autori ha in effetti fornito un contributo essenziale. Mi è sembrato quindi doveroso fare cenno, sia pure in termini quanto mai sommari, a tutti i saggi presenti nel volume.
di

La Prof.ssa Maria Letizia Bixio, autrice, e l’Avv. Francesco Posteraro
Approfondimenti:








